L’editoriale “L’ALIBI della domenica” è dedicato questa settimana al rapporto padre e figlio e al libro “Un’Odissea” di Daniel Mendelsohn.
Ieri pomeriggio ho seguito sul canale YouTube del Circolo dei Lettori di Torino la lectio di Daniel Mendelsohn “Odissea: un padre, un figlio, un’epopea”, una delle anteprime del Festival del Classico, edizione 2020 “Reloaded”.

È stata molto interessante e istruttiva, proprio come il libro omonimo dello scrittore statunitense (Long Island, 1960), pubblicato in Italia da Einaudi con la traduzione di Norman Gobetti. Io l’ho letto nel febbraio dell’anno scorso. Non sapevo che avrei perso mio padre qualche mese dopo, all’inizio di settembre. È da più tempo, tuttavia, che sto riflettendo sul tema del rapporto padre – figlio. Diciamo da almeno quattordici anni…
Padri, figli e fratelli…
Anche quest’anno molte delle letture che ho fatto sono incentrate, indagano o solo sfiorano questo tema. Su tutte “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij che ho riletto con mia moglie nei primi cinque mesi dell’anno, al ritmo di cinque pagine al giorno.
Proprio in questi giorni, poi, sto rileggendo le pagine finali del capitolo sesto di “Giuseppe in Egitto” di Thomas Mann, intitolato “La toccata”. Anche in questo caso si tratta di una rilettura quotidiana, una sorta di esercizio zen. Spesso vien voglia di voltare pagina per non interrompere il filo della narrazione, ma con un piccolo sforzo rispetto l’imposizione che mi sono dato e rimando al giorno successivo il prosieguo della storia.
Tra i vari motivi per cui Giuseppe si nega alla bella Mut-em-enet (Eni per gli amici), la moglie del suo padrone Potifar – sono ben sette e tutti strettamente connessi tra loro! – c’è il ricordo del padre Giacobbe. “Il padre! Era questo il quinto motivo, se pur non addirittura il primo, sovrastante ogni altro”.

E qualche giorno prima ho assistito all’incontro con Hisham Matar e Benedetta Tobagi per il Festival Dedica 2020 di Pordenone. Non ne hanno parlato molto, almeno apertamente, ma in sottofondo c’era sempre il tema del padre e della sua perdita, un’esperienza tragica che accomuna i due scrittori.
Matar ha perso il padre nelle carceri di Gheddafi, Walter Tobagi invece è stato assassinato da terroristi di estrema sinistra nel 1980, quando Benedetta aveva poco più di due anni. Curiosamente il tema della figura del padre compare anche nel romanzo “L’ultima notte del Rais” di Yasmina Kadra (pseudonimo di Mohamed Moulessehoul) che ho letto nei giorni del Dedica Festival.
Mendelsohn Senior & Junior
Ma torniamo alla lectio di Daniel Mendelsohn al Festival del Classico. Lo scrittore americano ha esordito con una domanda che si sente spesso rivolgere: perché leggere i classici? “Perché la natura umana è sempre la stessa, non è mai cambiata”, è la sua risposta, che condivido appieno.
Lo scrittore ha poi presentato la figura di suo padre Jay, una persona molto diversa da lui (quanto lo possono essere, appunto, un padre e un figlio…). Scienziato l’uno, letterato l’altro. Chiuso e introverso il genitore, più espansivo il figlio. A unirli la convinzione dell’importanza dell’educazione. Jay era orgoglioso del successo accademico del figlio, ma anche la sua propria era una storia – molto americana, riconosce Daniel – di successo personale.
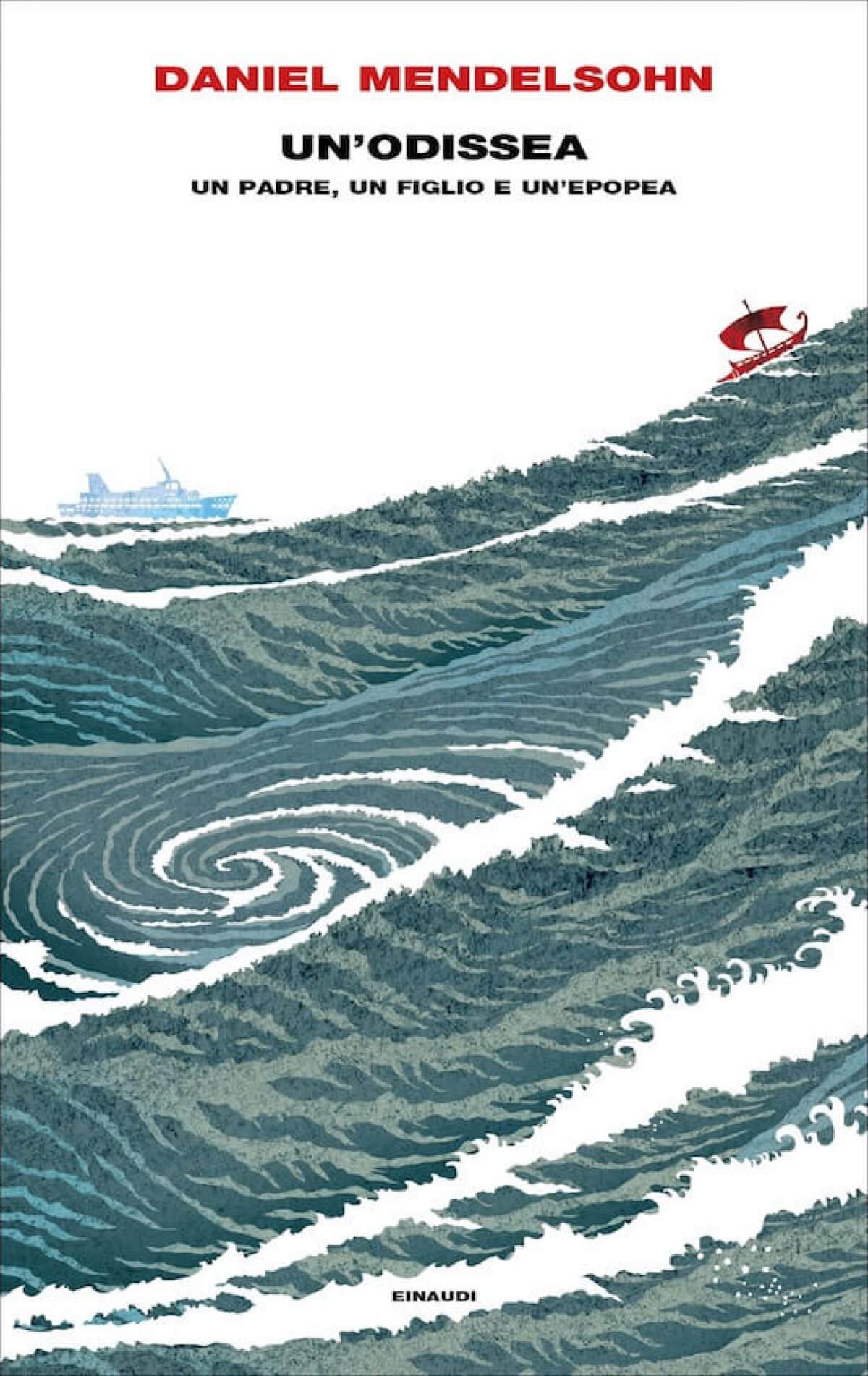
Uno dei temi fondamentali nell’Odissea di Omero è il problema dell’identità. Quando Ulisse riesce a ritornare a Itaca si trova ad affrontare avventure non meno pericolose di quelle fronteggiate per mare. Deve nascondersi e farsi riconoscere, dal figlio Telemaco, dal padre Laerte, dal porcaro Eumeo, dalla nutrice Euriclea, dal cane Argo e infine dalla moglie Penelope.
Il letto di Ulisse
A questo punto Mendelsohn ha citato un brano dall’inizio del suo libro. Ne riporto un passo.
Per non dover fare due volte in un giorno quel viaggio di tre ore, di solito mio padre si fermava da me a dormire nella camera degli ospiti che uso come studio, e si allungava sul divano letto striminzito che da bambino era stato il mio giaciglio – un basso letto di legno che aveva costruito con le sue mani quand’ero stato abbastanza grande da abbandonare il lettino con le sbarre. C’era una cosa riguardo a quel letto che sapevamo solo io e lui: era stato ricavato da una porta, una dozzinale porta cava a cui mio padre aveva attaccato quattro gambe robuste, assicurandole con staffe metalliche oggi altrettanto salde di cinquant’anni fa, quando aveva unito il metallo al legno”.
Ai lettori dell’Odissea non sfuggirà il carattere “odissiaco” di questo aneddoto. È proprio rivelando il segreto dell’originale costruzione del letto matrimoniale che Ulisse darà prova definitiva della propria identità a Penelope.
Durante il semestre in cui Mendelsohn Senior seguì il corso di Daniel, al rapporto tra padre e figlio s’intrecciò quello tra docente e studente, con “rapporti di forza” (e qui le virgolette non bastano) invertiti rispetto a quelli famigliari. Senza contare che l’attempato alunno – allora ottantunenne – sfidava apertamente l’autorità del professore. Il suo atteggiamento ebbe almeno due effetti: provocò una reazione nei compagni di classe, solitamente piuttosto restii a farsi coinvolgere personalmente nelle lezioni.
Ma soprattutto spinse Daniel a rileggere con occhi nuovi il poema omerico, grazie alla freschezza (“freshness”) con cui il padre si approcciava all’Odissea. Jay non faceva mistero della scarsa stima che nutriva verso Ulisse: “in realtà non è un «vero» eroe (perché, diceva, è un bugiardo e tradisce la moglie!)”. Anche come capo, secondo lui, non valeva nulla, visto che arrivò a casa da solo, dopo aver perso per strada tutti i compagni. Quello fu senza dubbio il più impegnativo dei corsi di Mendelsohn Junior!
A cementare il rapporto tra padre e figlio fu la crociera “sulle tracce di Ulisse” che i due compirono dopo il corso universitario. Anche in quell’occasione il padre mostrò un lato di sé che il figlio non conosceva, affascinando i compagni di viaggio con i racconti della sua infanzia. Saranno state la “magia del Mediterraneo”, la ribalta vacanziera, la consapevolezza di aver raggiunto un grado d’intimità mai prima toccato, fatto sta che il padre stupì ancora una volta il figlio.
L’ultimo capitolo della vita del genitore avrebbe riportato Daniel a riflettere sul tema odissiaco del riconoscimento, toccandolo nel profondo con l’esperienza diretta.
Mendelsoh ha chiuso la sua lectio con una celebre citazione di Italo Calvino: “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. Ecco, possiamo dire che i classici sono i nostri padri. Possiamo contestarli, rifiutarli, ignorarli o disconoscerli oppure, al contrario, apprezzarli, amarli, frequentarli e averne cura. Comunque sia, siamo loro figli.
Saul Stucchi
Daniel Mendelsohn
Un’Odissea
Un padre, un figlio e un’epopea
Traduzione di Norman Gobetti
Einaudi, Frontiere
2018, 320 pagine
20 €