 Lunedì 14 novembre si è tenuto presso la Sala delle Colonne del Grande Museo del Duomo di Milano un incontro dal titolo “La Biblioteca di Fozio I, Patriarca di Costantinopoli. Lo Scisma d’oriente. Il confronto per il primato tra Roma e Costantinopoli”.
Lunedì 14 novembre si è tenuto presso la Sala delle Colonne del Grande Museo del Duomo di Milano un incontro dal titolo “La Biblioteca di Fozio I, Patriarca di Costantinopoli. Lo Scisma d’oriente. Il confronto per il primato tra Roma e Costantinopoli”.
Dopo i saluti di Monsignor Gianantonio Borgonovo, il moderatore Armando Torno (motore primo dell’iniziativa) ha segnalato che la prima edizione della “Biblioteca” di Fozio pubblicata dalle Edizioni della Scuola Normale di Pisa è già esaurita, ricordando che un’edizione critica era attesa dagli studiosi da almeno settant’anni. Ha poi dato la parola a Michele Ciliberto che in quella prestigiosa università insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea. Il professore ha ricordato che da subito l’Università, innovatrice e insieme custode della memoria contro la barbarie, si è mostrata lieta di pubblicare il testo, fedele alla propria tradizione (sulla scia di Gentile) di pubblicare i classici.
L’intervento di Tullio Gregory
Tullio Gregory ha aperto il suo intervento introducendo la “Biblioteca” di Fozio: “forse non tutti sanno cosa sia…”. È una raccolta di schede di letture, un “thesaurus”, non un libro. È il grande capolavoro della cultura bizantina e rivolgendosi al professor Canfora l’ha esortato: “Ci dia anche Suida”, per completare il quadro con la seconda, fondamentale, colonna.
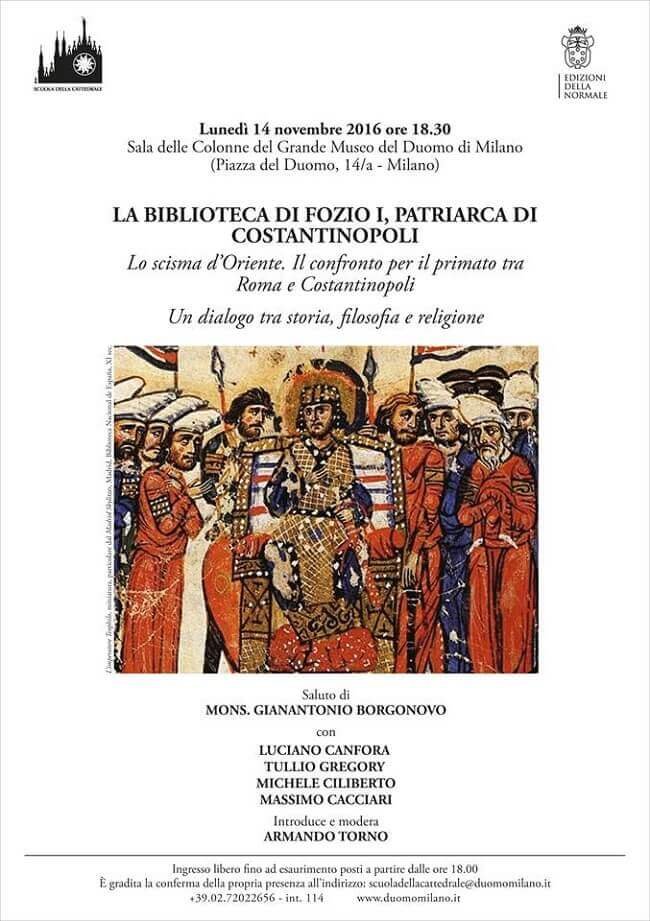 Si è poi soffermato su alcuni “miti” che tanto danno fastidio a Canfora. Perché, per esempio, nella Biblioteca non ci sono i grandi classici? Perché erano libri già noti ai destinatari dell’opera. La caccia ai pregiudizi storiografici di Canfora si concentra inoltre sulla “ambasceria in Assiria” di Fozio. Il filologo barese, che ben conosce anche i Settanta, ha compreso che il riferimento di Fozio è alla biblica cattività babilonese. Il patriarca allude dunque alla propria prigionia sotto i suoi persecutori. In prigione non aveva a disposizione i suoi libri, ma gli “schedaria”, gli appunti presi durante gli incontri con i collaboratori. Si tratta di schede di lunghezza molto varia.
Si è poi soffermato su alcuni “miti” che tanto danno fastidio a Canfora. Perché, per esempio, nella Biblioteca non ci sono i grandi classici? Perché erano libri già noti ai destinatari dell’opera. La caccia ai pregiudizi storiografici di Canfora si concentra inoltre sulla “ambasceria in Assiria” di Fozio. Il filologo barese, che ben conosce anche i Settanta, ha compreso che il riferimento di Fozio è alla biblica cattività babilonese. Il patriarca allude dunque alla propria prigionia sotto i suoi persecutori. In prigione non aveva a disposizione i suoi libri, ma gli “schedaria”, gli appunti presi durante gli incontri con i collaboratori. Si tratta di schede di lunghezza molto varia.
Gregory ha insistito sulle parole con cui si apre il manoscritto Marciano Greco 450, praticamente coevo a Fozio, ovvero “Fozio, vescovo di Costantinopoli e patriarca ecumenico”. La rimozione di queste parole da tutte le edizioni e traduzioni è molto grave perché significa dimenticare tutta una lunga e cruenta lotta. Si perde un elemento caratterizzante dell’opera stessa.
Ma come lavorava Fozio? Possiamo farcene un’idea confrontando le schede con le opere rimasteci. La Biblioteca è preziosa anche perché contiene testimonianze fondamentali per la storia della chiesa, in particolare su alcuni sinodi sui quali non abbiamo altre fonti.
Gregory ha concluso sottolineando il piacere di leggere libri inutili, che in realtà soddisfano e stimolano. La lettura disinteressata offre il grande piacere di vagare e divagare tra i libri.
 L’intervento di Massimo Cacciari
L’intervento di Massimo Cacciari
Nel suo intervento Massimo Cacciari si è soffermato sul problema della presenza (o non presenza) della filosofia nelle opere di Fozio e ha ricordato la guerra tra le due Rome per il primato della cristianità. In quella battaglia di civiltà era immerso e coinvolto Fozio. Fondamentale era il tema della memoria: vinceva chi si ricordava di più, chi più conservava in sé.
I Bizantini ignoravano i Latini e viceversa, così quello tra loro era un dialogo tra sordi. Basti come esempio il fatto che l’imperatore bizantino Michele III si rivolse a papa Niccolò I dicendo che i Latini parlavano una lingua incomprensibile. A confronto erano due concezioni differenti del mondo e spesso il confronto degenerò in scontro.
Il filosofo ha individuato un filo rosso che tiene insieme molte schede della Biblioteca, ovvero la ripresa della tradizione medio-neoplatonica. Cacciari ha concluso domandando a Canfora il motivo per il quale l’opera venne pubblicata soltanto all’inizio del Seicento, anche se Aldo Manuzio l’aveva già per le mani a Venezia un secolo prima.
La parola a Luciano Canfora
A chiudere l’incontro è stato l’intervento del professor Canfora che ha esordito rimarcando che “il tema Fozio divide sempre. Il che è un bene, naturalmente”. Secondo la sua opinione andrebbe sfumata l’osservazione di Cacciari sulla reciproca ignoranza tra Latini e Bizantini: da molti indizi si evince che la conoscenza fosse maggiore rispetto a quanto sostenuto in passato.
 Il filologo ha poi ricordato l’avventura del bibliotecario Anastasio, l’unico a conoscere il greco alla corte papale, che si trovò per caso a Costantinopoli durante il concilio che condannò Fozio. L’imperatore Basilio sacrificò il patriarca per avere la Bulgaria. E gli Assiri? Gli infedeli di cui parla Fozio sono i messi del papa. Il bibliotecario Anastasio ebbe l’accortezza di copiarsi di nascosto gli atti del concilio. L’imperatore aveva infatti ordinato che ne se facessero cinque copie, una per patriarcato e quindi una destinata a Roma, ma poi aveva mandato degli agenti a rubarla durante il ritorno dei messi papali che arrivarono a destinazione letteralmente spogliati di tutto.
Il filologo ha poi ricordato l’avventura del bibliotecario Anastasio, l’unico a conoscere il greco alla corte papale, che si trovò per caso a Costantinopoli durante il concilio che condannò Fozio. L’imperatore Basilio sacrificò il patriarca per avere la Bulgaria. E gli Assiri? Gli infedeli di cui parla Fozio sono i messi del papa. Il bibliotecario Anastasio ebbe l’accortezza di copiarsi di nascosto gli atti del concilio. L’imperatore aveva infatti ordinato che ne se facessero cinque copie, una per patriarcato e quindi una destinata a Roma, ma poi aveva mandato degli agenti a rubarla durante il ritorno dei messi papali che arrivarono a destinazione letteralmente spogliati di tutto.
Ristretto in prigionia, Fozio chiese di avere i propri libri, ma non li ottenne. Poté avere invece gli “schedaria”, (una “selva selvaggia”, l’ha definita Canfora). La Biblioteca è composta nella prima parte da recensioni e nella seconda da estratti. Perché questa struttura? Perché la Biblioteca non è un “libro”, ma quello che rimane degli “schedaria”. Ed è una fortuna per noi, perché così abbiamo ampi estratti di opere andate perdute. La Biblioteca è un cantiere aperto, incompiuto, un’opera non destinata alla circolazione, ma fortunosamente e fortunatamente messa in salvo.
Non circolò a Bisanzio e rimase inedita fino al 1606/7. Il cardinale Bessarione ne comprò due esemplari (sono i codici Marciano Greco 450 A e B) che “riemersero” durante il Concilio di Trento. In città (allora, come oggi) faceva freddo e i cardinali preferivano stare a Venezia… La “rinascita” del libro a metà del Cinquecento fece sentire l’esigenza di una traduzione. Ma c’era un problema: l’opera era all’Indice, dunque non si poteva stampare. Con una sorta di escamotage venne superato l’impedimento. Canfora ha concluso ricordando che noi non leggiamo Fozio, ma il lavoro di un’equipe. Come quella che ha dato vita a questa monumentale e imperdibile edizione.
Adesso sapete cosa leggeremo a puntate nel 2017 qui su ALIBI Online, una volta concluso il lungo viaggio nella “Storia della decadenza e caduta dell’impero romano” del Gibbon.
Saul Stucchi
- Fozio
Biblioteca
introduzione di Luciano Canfora
a cura di Nunzio Bianchi e Claudio Schiano
Edizioni della Normale
pp. XCIV-1300, 120 €