Anni fa, avevo letto uno dei libri – sempre magnificamente problematici – di Predrag Matvejević: “Tra asilo ed esilio”. Bel titolo, che rende il complesso rapporto tra noi e i luoghi estranei in cui le vicissitudini dell’esistenza ci hanno portati ad abitare, come pure il legame che, malgrado tutto, continua a vincolarci alla nostra terra d’origine.
È proprio la tematica affrontata da Marino Magliani in “L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi” (pubblicato dal sempre meritorio editore romano Exòrma), come già era accaduto con un altro suo piccolo-grande testo, “Canale Bracco” (Fusta Editore).
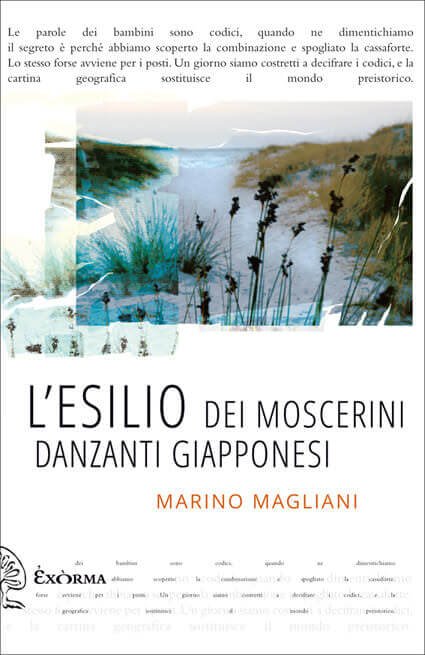
L’io narrante, o il protagonista, è, come l’autore, un traduttore dallo spagnolo, che divide il suo tempo tra l’Olanda in cui vive da decenni e la Liguria natale. Ma gli ambienti evocati dalla memoria sono anche altri: la Costa Brava, le remote Canarie, la Pampa argentina e – agognato sempre, eppure non ancora visitato – il Portogallo.
Si trovi egli ad arrancare sulle pendici boscose e cespugliate dell’Appennino o a passeggiare lungo le dune spoglie del Mare del Nord, nel vento afoso di Tenerife o in quello salmastro e gelido di Zeewijk, all’età di cinque anni oppure superati i cinquanta, il suo atteggiamento è perennemente montaliano: “Lo sguardo fruga d’intorno, / la mente indaga accorda disunisce / nel profumo che dilaga / quando il giorno più languisce”.
Il libro si apre con una caccia alle mosche e con la descrizione della carta moschicida: particolare che mi ha richiamato un racconto breve di Robert Musil, all’inizio delle “Pagine postume pubblicate in vita”.
Poi il filo della storia prende a vagare nello spazio e nel tempo, conducendo con sé, a ogni svolta, un lettore assolutamente partecipe, grazie alla sapienza stilistica e all’efficacia espressiva di ogni singola frase – e anche, perché no, all’accattivante ambiguità circa il “tu” cui la narrazione è rivolta, che pare mescolarsi e sovrapporsi al “lei” col quale si designa una vecchia amica ritrovata (o più probabilmente mai perduta).
Devo dire che queste pagine, pur riferendosi a una vita diversa dalla mia, mi hanno ridestato immagini finora disperse nella marea infinita dei ricordi (ne cito qualcuna a casaccio): i pigiami marroncini dell’ospedale militare, l’attrito tra il dialetto della quotidianità e l’italiano della scuola (e della TV), l’esame di seconda elementare, le pluriclassi di paese…
Infiniti sono poi i richiami e le consonanze letterarie. C’è, indubbiamente, Francesco Biamonti (“Sono da cancellare, la mia vita non conta nulla, i miei natali non hanno importanza, il mio paese è insignificante…”; “Il vento largo”; “La fronda di un cipresso attraversa un pezzo di cielo”).
C’è il poeta portoghese Miguel Torga (pag. 29). C’è il Borges del racconto “L’altro” (Gregorio adulto che conversa con sé stesso bambino – ma il nome di battesimo è marcatamente biamontiano: come non pensare al Grigoeu dell’Angelo di Avrigue, col suo “cigolio del carro”?).
C’è Haroldo Conti, che proprio in quel frangente veniva tradotto. E poi ci sono il Serchio di Ungaretti, l’oltresiepe di Leopardi, le colline “da cui si vede il mare” di Pavese, gli ulivi di Boine, l’opaco di Calvino, e soprattutto c’è Antonio Tabucchi, evocato, citato e parafrasato durante un po’ tutto il libro.
Voglio ora annotare e chiosare qualche punto in cui il testo ha incrociato la mia esperienza personale.
“Ma dei rovi qui non importa nulla a nessuno, gli olandesi non possono ammettere che un arbusto divori un territorio. Loro domano la natura, avevano l’acqua che consumava la terra e l’hanno incanalata, e se avessero i rovi li estirperebbero”. La mia percezione dell’Olanda mi dice qualcos’altro, sia a Utrecht (“Le pianticelle che vediamo spuntare dai marciapiedi, dai ponti e dai muri non sono lasciate crescere per incuria, ma volutamente: come connettivo tra le pietre da costruzione si è infatti usato, in luogo della malta di cemento, il gesso, così da consentire alle piante calciofile, quali la sassifraga o il ciombolino, di attecchirvi”) che nel centro storico di Amsterdam (“Valicando un ponticello a bilanciere, in ferro grigio, raggiungiamo la sponda opposta e la seguiamo. Come spiegava il libriccino di Utrecht, si lasciano crescere spontaneamente pianticelle nelle commessure dei marciapiedi e a ridosso delle case, oltre che nelle aiuole, a volte piccolissime, che le orlano, e nei vasi disposti vicino agli ingressi”) – così mi ero annotato nei taccuini di viaggio.
Del tutto aderente alle analogie riscontrate nei miei itinerari lusitani (in particolare a Porto) è invece quanto l’io narrante afferma subito dopo: “Mi piacerebbe discorrere del Portogallo, e del fatto che in qualche modo ci sono terre che in comune con la Liguria hanno un senso di estremità. Forse ci giocano la luce, i marciapiedi, le finestre. La malinconia. Portogallo e Liguria…”.
Ricordo di aver preso pure io “il traghetto gratuito per attraversare il Noordzeekanaal” e di aver notato le “vetrate” al pianterreno, che in Olanda caratterizzano le abitazioni unifamiliari, o gli incongrui ulivi piantumati in enormi vasi rimovibili (nella piazza di Hoorn, per esempio).
Infine, la data finale – “Zeewijk, inverno 2026” – mi ha fatto sorridere per l’accostamento alla cronologia stralunata del “Diario di un pazzo” di Gogol’. Ma un analogo sfasamento temporale (unitamente alla tematica dell’esilio – “per cui bello di fama e di sventura…” – e ad alcune immagini dei “suoi” arroccati borghi liguri) Magliani l’ha ripreso nell’ultimo romanzo finora apparso, “Prima che te lo dicano altri” (Chiarelettere).
Non credete che sarebbe il caso di passare un po’ di tempo in compagnia dei suoi libri?
Marco Grassano
Marino Magliani
L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi
Exòrma
2017, 180 pagine
14,50 €