Una storia fattuale e una mitopoiesi insieme (quella che i russi non fanno che costruire sul loro paese) – così ce le racconta lo storico inglese Orlando Figes nel bel volume rilegato e illustrato, Storia della Russia: mito e potere da Vladimir il grande a Vladimir Putin, tradotto recentemente per Mondadori da Tullio Cannillo.
Specialista fra i maggiori sull’argomento, Figes aveva già scritto alcuni volumi sulla Russia, fra cui La danza di Nataša e La tragedia di un popolo, il secondo sugli anni della rivoluzione bolscevica (un sogno tutt’altro che esaltante per lo studioso).
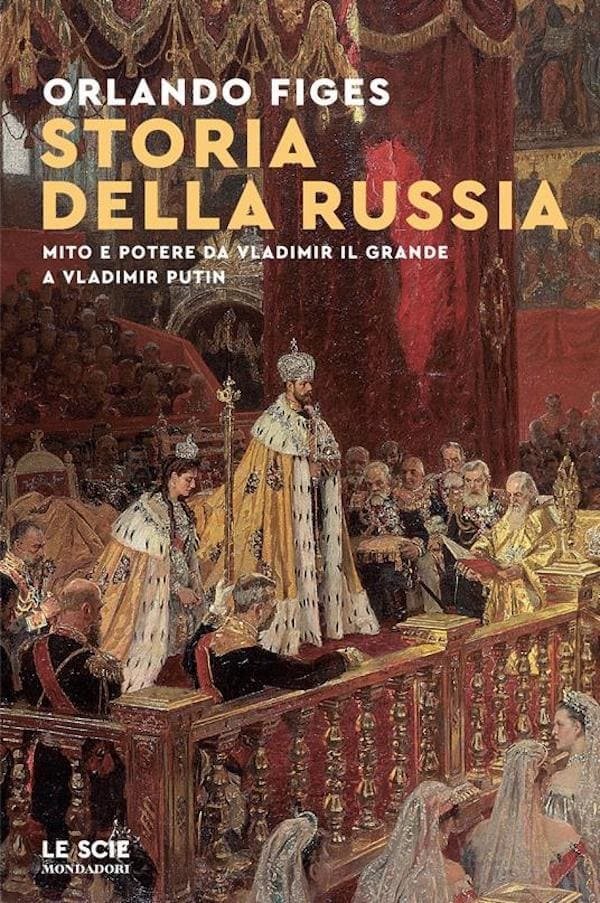
La premessa necessaria del lavoro è che se ogni paese – diremmo, ogni popolo – ha tentato di edificare un racconto di sé stesso, nessuno come quello russo ha incessantemente impiantato su un passato mitologico la propria peculiare modalità di stare al mondo. Un uso della storia finalizzato all’arte del governo che nello specifico si è caratterizzato come un tema con (poche) variazioni di tipo sostanzialmente vittimistico-eroico, quello di una Madre Russia imperiale e religiosa via via impegnata da una parte a convogliare in un’unica, “sacra” entità etnie diverse, dall’altra a fronteggiare nemici, reali e presunti: i mongoli a est, i popoli germanici a ovest, l’Europa e l’Occidente tutto.
Una versione autoprodotta in patria dai suoi uomini forti che si scontra storicamente con l’interpretazione e le ragioni altrui – l’Ucraina è solo l’ultimo atto di questa sceneggiatura che guarda al paese invaso come a una piccola ancella senza possibilità di autonomia, quasi gli ucraini non esistano in quanto ucraini (se insistono a “esserlo”, sarebbero ontologicamente nazisti).
Per Figes né Russia né Ucraina possono accampare nella Rus´ di Kiev (una confederazione medievale che incrociava popoli diversi, specie slavi orientali e variaghi) la matrice originaria della loro storia. Matrice che Putin, com’è noto, ha voluto individuare segnatamente nel principe Vladimir, innalzandogli un monumento nel 2016 seguito da un discorso tanto solenne quanto discutibile (non casualmente condiviso dall’attuale patriarca Kirill), per il quale Vladimir avrebbe creato uno stato forte e unito, tenendo insieme anche Bielorussia e Ucraina sotto le insegne del cristianesimo ortodosso e di un’unica lingua – laddove per gli ucraini tutto ciò rappresenta un vero e proprio furto della memoria storica e della verità (di Vladimir peraltro non si sa granché).
Figes ricorda la massima di Huxley, per il quale “Chi controlla il passato… controlla il futuro, chi controlla il presente, controlla il passato”. Per il potere russo, ossessionato dal mito al servizio dell’ideologia, questo è vero al massimo grado, per cui è impossibile studiarne la storia senza guardare al racconto che continuamente la decostruisce e la reinventa. Con delle costanti innegabili, che (si tratti della “Santa Russia”, o della Terza Roma) rinviano a un perseverante autoritarismo, all’autoinvestitura di una missione speciale (anche religiosa), a un assunto nazionalistico di essere altro e meglio rispetto agli occidentali. E di doverli combattere.
Se il mito di Vladimir fu funzionale al potere di Ivan il terribile, dei Romanov e oggi di Putin, Figes fa notare che anche per una sovrana, Caterina la Grande, notoriamente più sensibile alle sirene del modernismo occidentale e sostenitrice della corrente minoritaria dell’idea che la Russia fosse stata fondata da tedeschi, riteneva che “un paese vasto come la Russia dovesse necessariamente essere governato da un’autocrazia”.
Siamo qui alla seconda direttrice della lettura di Figes: al pari del mito per comprendere la Russia è necessario tener conto dell’immensità del suo territorio, dunque della confluenza e dello scontro con molteplici popoli, slavi, mongoli, cosacchi, bizantini, ottomani etc, da cui una persistente mentalità paranoica nell’urgenza di difendere – o estendere -i propri confini.
Problematici assai, e però non necessariamente respingenti: le celebrate icone (“punto focale delle emozioni spirituali dei credenti”) giunsero dalla tradizione bizantina e soltanto col tempo acquisirono la peculiarità russa che ne fece un capitolo importante della storia dell’arte, fino a Andrej Rublëv, non a caso protagonista di un memorabile film di Andrej Tarkovskij.
Peraltro, Figes è bravo nel mostrare come il cinema si inserisca perfettamente in questa dialettica fra storia fattuale e immaginario – si veda il caso dell’Aleksandr Nevskij di Ėjzenštejn: quando esce, nel 1938, il film riceve tributi e onori dallo stesso Stalin, salvo sparire dalle sale dopo il patto Molotov-Von Ribbentrop, e ancora riemergere a suon battuto dopo l’attacco dei nazisti. Nevskij nel tredicesimo secolo aveva combattuto prima gli svedesi, poi proprio i tedeschi, mentre dell’Orda d’Oro “era stato fedele servitore”: considerò gli occidentali più pericolosi dei mongoli e soprattutto nulla avrebbe potuto contro il loro strapotere.
Fu solo in quegli anni che Mosca cominciò a uscire dalla dimensione del piccolo villaggio e a crescere. Quando, dopo due secoli di umiliazioni, i tatari vennero sconfitti nella battaglia decisiva di Kulikovo (altra pietra miliare della mitopoiesi russa), la loro cultura aveva penetrato la mitica “anima russa”, al punto che Herzen o Bucharin avrebbero paragonato le dittature rispettivamente di Nicola I e Stalin a quella di Gengis Khan – contrariamente alla storiografia ufficiale, va da sé, e slavofila, preoccupata di interpretare la Realpolitik di Nevskij come strategia fondamentale per la difesa della Cristianità (e annesso risentimento per l’ingratitudine dell’Occidente).
Il culto della grande Russia imperiale non mancò con Ivan il Terribile (col film a lui dedicato ancora Ėjzenštejn sperava di far intendere a Stalin l’orrore del suo potere, Koba invece lo chiamò in privato e contrattaccò dicendogli che lo zar del regista era fin troppo amletico e che la ferocia di quello vero era stata necessaria). Con Caterina la Grande, nonostante gli iniziali fervori illuministici, si assiste a un’espansione dei territori tale da determinare ancora oggi le pretese dei siloviki al potere. In quest’ottica, l’intera Ucraina (Crimea compresa) sarebbe russa perché strappata agli ottomani, dimenticando, i russi, la presenza cospicua degli etmanati cosacchi – sono gli anni, quelli settecenteschi, della fondazione di Odessa (“vi si sente il profumo dell’Europa”, scrisse Puškin).
A favorire la politicizzazione della storia russa non poteva ovviamente mancare la vicenda napoleonica. Caso esemplare di come siano state le vittorie, principalmente, a cementare il rapporto fra potere e masse dell’immenso paese, talché la memoria russa ha potuto oggi riabilitare persino la figura di Stalin, non in quanto comunista, tutt’altro, ma come leader nazionalista in grado di resistere ai nazisti (nei libri di storia russi gli accordi del ’39 con la Germania vengono omessi, o considerati fuori dalla guerra, che essi fanno iniziare nel ’41). Così, scrive Figes, pure le vicende odierne potranno essere lette dal popolo russo a seconda degli esiti del conflitto, benché la maggioranza consideri quello ucraino una sorta di tradimento in favore degli empi valori occidentali.
A proposito di costanti, per lo studioso inglese il problema storico che oggi si ripete è la mancanza di una “società” significativa che funzioni da argine allo strapotere degli apparati di potere (il leader, i siloviki, l’FSB etc). La storia della cultura critica russa, fuori dalle grandi città, è sempre stata appannaggio di circoli ristretti (pensiamo al movimento decabrista di Pietroburgo, perseguitato da Nicola I) e, nonostante le ribellioni dei contadini, un certo loro spirito comunitario e un carsico desiderio di libertà e giustizia, non si è mai trasformata nelle strutture consolidate di un vero stato di diritto.
Belinskij non poté esimersi dallo scrivere che la Russia “non ha bisogno di prediche (ne ha sentite abbastanza), non di preghiere (ne ha recitate abbastanza); ha bisogno che nel popolo si risvegli il senso della dignità umana, trascinato per tanti secoli nel fango e nel letame; ha bisogno di una dottrina giuridica e di leggi che non si ispirino all’insegnamento della Chiesa, ma al buon senso e alla giustizia, e che vengano applicate con la massima severità”. Dostoevskij partecipò ai suoi circoli ma dopo l’arresto e gli anni di lavori forzati in Siberia, si fece portatore di un ideale russo reazionario e millenaristico, antioccidentale (che nulla toglie alla grandezza dello scrittore, di questi strani tempi meglio ribadirlo, e ugualmente diremmo di Gogol’ che riteneva sacrosanto per i proprietari terrieri picchiare a morte i servi qualora fosse necessario).
Quanto alla rivoluzione di Ottobre, per una cui analisi e storia più dettagliata rimandiamo al citato, monumentale La tragedia di un popolo (sempre da Mondadori), per Figes non fu solo una tragedia, ma una rivoluzione inutilmente cruenta, perché, dopo la rivoluzione di Febbraio non c’era un regime ma un sostanziale vuoto di potere. I bolscevichi fecero l’errore di non tener conto di una possibile alternativa, ossia dell’intenzione dei soviet di tenere insieme tutta l’area di sinistra. La scelta leninista della violenza provocò la guerra civile, e poi milioni di morti per carestie (l’ineludibile memoria ucraina dell’Holodomor), assassinii, stupri che accompagnarono la requisizione delle terre e la collettivizzazione forzata.
In un certo senso, nemmeno lì, nonostante l’ideologia marxista, la tradizionale “anima russa” si fece da parte: nella tensione urlata di un nuovo mondo, di una trionfale palingenesi, non mancarono i toni parareligiosi.
Dalla Russia odierna si direbbe non resta che fuggire. Fare opposizione sembra impossibile come negli anni di Stalin, solo che oggi accade all’interno di un capitalismo criminale, di una ricchezza di cui Putin ha lasciato che gli oligarchi si appropriassero pur di non interferire con il suo potere. E vendendo una propaganda antioccidentale che ha spostato verso l’esterno i problemi e la delusione postcomunista di milioni di sovietici.
“Lo considero un criminale di guerra”, ha detto Gleb Karakulov, ex guardia del corpo di Putin in una recente intervista. Secondo l’uomo, l’autocrate del Cremlino sarebbe disinteressato alla rete. Questo andrebbe considerato come un appunto riguardante l’uomo, perché se c’è qualcosa che manca all’imperdibile libro di Figes è proprio un approfondimento sulla guerra internettiana degli ultimi anni, sulla deliberata costruzione di una strategia della confusione, quella enucleata nella dottrina Gerasimov, che negli ultimi decenni ha orientato la guerra all’Occidente di Putin attraverso bot, troll e social: la penetrazione in Occidente delle suggestioni russe, del falso programmatico, non solo fra i sovranisti, dice che il cosiddetto soft power moscovita è tutt’altro che morbido e indolore.
La lezione più ascoltata da Putin resta quella del pensatore del secolo scorso Ivan Il’in, ferocemente contrario all’ipotesi di un’Ucraina separata e convinto sostenitore di una speciale missione della Russia nel mondo, fascista e religiosa, nel nome della quale assistiamo ai massacri oggidiani.
Michele Lupo
Orlando Figes
Storia della Russia
Mito e potere da Vladimir il Grande a Vladimir Putin
Traduzione di Tullio Canillo
Mondadori
Collana Le Scie
2023, 384 pagine
26 €