Sono usciti di recente due libri assai diversi ma entrambi interessanti sul tema delle neurodivergenze. Uno lo firma Temple Grandin, figura assai nota di cui Adelphi manda in libreria Pensare senza parole, lavoro in realtà già tradotto da noi molto tempo fa col titolo, pensato dapprima anche dalla casa milanese, Pensare in immagini. L’altro è L’impero della normalità. Neurodiversità e capitalismo, di Robert Chapman, edito da Mimesis, che mostra un evidente richiamo politico.
Grandin – neurodivergente come Chapman – analizza col massimo gradiente possibile di scientificità un aspetto particolare dell’autismo, quello di chi appunto pensa per immagini più che attraverso il linguaggio. È un libro che precede il suo titolo più noto, Il cervello autistico, opera mai citata da Chapman, che forse lo riterrà troppo vicino a una marca essenzialista che in tutta evidenza non condivide.
Chapman inquadra la questione della neurodivergenza in una cornice ideologica che tende a ridiscuterne gli stessi presupposti culturali, le storture delle costruzioni sociali e l’impalcatura capitalista che li sostiene. In realtà, sebbene tra i due passino un paio di generazioni, in entrambe le posizioni non manca il tentativo di tenersi dentro un corretto equilibrio.
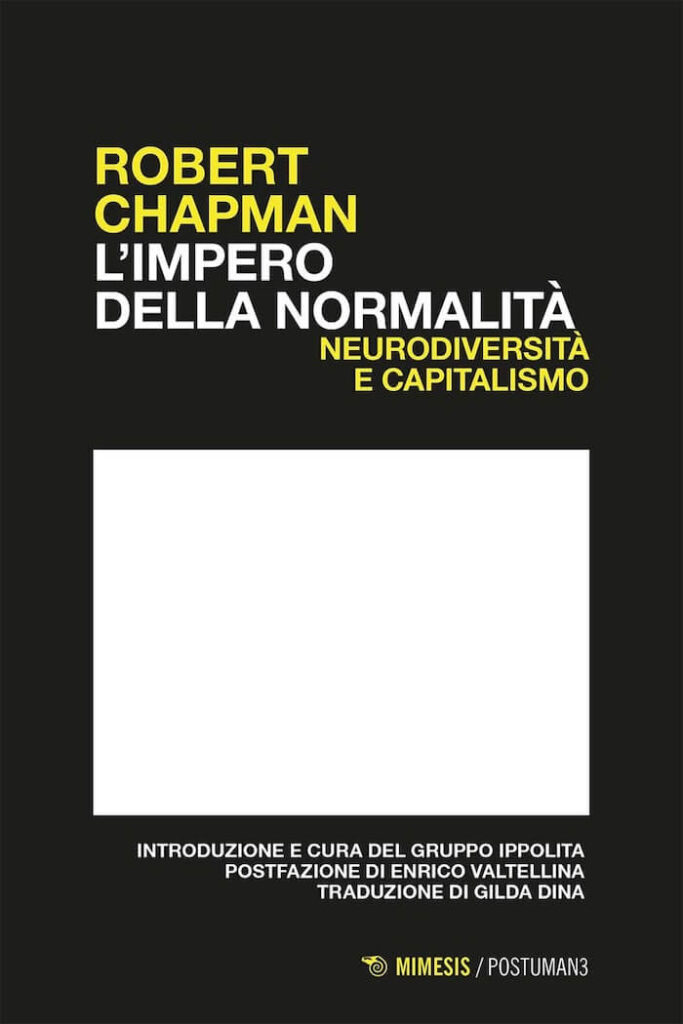
Grandin conosce, e ripercorre a ritroso come fa Chapman, la storia dei DSM comprese le sue causali socioeconomiche, così come Chapman non mette in discussione il concetto di disabilità ma lo articola, da una prospettiva marxista, in un’architettura variabile che non la separa nettamente dalla cosiddetta normalità. Il suo è uno sguardo politico ma certo non ingenuo (interessanti le pagine in cui demolisce l’impianto dell’antipsichiatria).
Dal canto suo Grandin scrive: “Una delle ragioni che mi ha spinto a scrivere questo libro è che la perdita di competenze nel nostro paese mi spaventa”: varie pagine sono spese come un documentato j’accuse contro l’impostazione delle scuole americane. Che dimenticano quelle come lei: “Il mondo non mi arriva attraverso sintassi e grammatica, bensì attraverso immagini (…). Le parole mi forniscono informazioni, ma non ne ricavo associazioni emotive. Per provare un’emozione, ho bisogno di vedere qualcosa o di rievocare un’immagine visiva.”
Sì che la paradossale fortuna professionale della Grandin è dipesa da un modo tutto peculiare di vedere le cose, quella dei pensatori visivi. Che arricchiscono il mondo – immaginarne uno, scrive, “senza artisti, progettisti industriali o inventori; senza elettricisti, meccanici, architetti, idraulici o muratori”.
Il pensiero visivo è un modo differente di risolvere problemi, orientarsi nel mondo e interpretarlo. Sono persone “che riescono a localizzare facilmente un luogo in cui sono stati una volta soltanto, perché il loro GPS interiore ne ha registrato i punti di riferimento visivi, di iper-sistematizzatori che faticano a svolgere persino i compiti sociali più semplici della vita quotidiana, come stringere e mantenere relazioni, ma riescono a individuare pattern in natura o attraverso la sperimentazione che ad altri semplicemente sfuggono”.
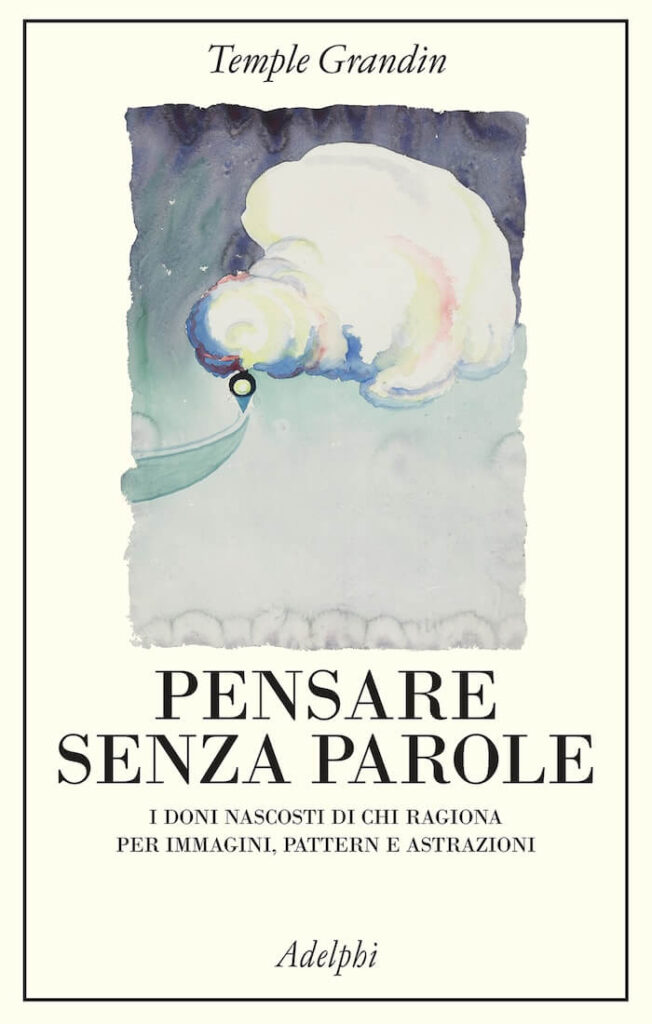
Sulla scia di Baron-Cohen, Grandin ritiene che spesso i neurodivergenti – che si tratti di pensatori visivi o verbali – sembrerebbero avere una marcia in più alle voci creatività e invenzioni. Grandin stessa si è sottoposta per anni alle indagini tramite scansioni cerebrali, constatando le differenze di volumi, di forme che (assieme alle variabili genetiche) determinerebbero le cause della diversità; ma ricorda altresì il pericolo delle etichette diagnostiche che frenano la possibilità di aggiustare il tiro in funzione di una vita meno angosciosa.
Pensatori di questo tipo furono Edison o Michelangelo – laddove l’asperger Bill Gates conferma la serie di tipi dalle scarse abilità sociali assieme a un’intensa capacità di concentrazione, una voce monocorde, un limitato contatto visivo e il dondolio.
Naturalmente, fuori dall’orbita del genio, la vita di un neurodivergente può risultare molto meno divertente – il prodigio si traduce in stigma, che, nell’ottica di Chapman, nasce all’interno di un discorso politico, dove il neurotipico per lo più coincide con l’individuo adatto all’odierno capitalismo.
Non che Chapman neghi la cogenza di una segnaletica genetica o neurologica, ma neurodivergenti in un determinato contesto sociale lo si può diventare, e soprattutto la logica delle classificazioni non risponde in nessun modo a un’episteme oggettiva decontestualizzata dall’ideologia – quella esplosa nell’Ottocento con il capitalismo e le sue sovrastrutture, eugenetica e ossessione nomenclatoria comprese (artefice Francis Galton).
Non ignaro della lezione di un Mark Fisher, conclamata la maggiore probabilità di fenomeni depressivi nei neurodivergenti, Chapman rimarca la stretta sempre più soffocante che le modalità del capitalismo odierno accentuano su determinate condizioni: se è vero che sono migliorate le possibilità diagnostiche, le sollecitazioni psichiche e sensoriali oggi sono tali da considerare un numero spropositato di persone catalogabili in nuove presunte disabilità.
Precarizzazione, bassi salari, imperio dell’efficienza per la corsa cieca del capitale: quello di Chapman si autodefinisce “marxismo autodivergente”, che se fa la tara all’ideologia sottesa all’aumento di diagnosi di autismo, si oppone anche alle soluzioni facili della psicologia che si sostituisce alla psichiatria: seguire il modello libertario ma destrorso inaugurato negli anni Settanta da Thomas Szaz avrebbe impedito il riconoscimento dei diritti delle persone effettivamente disabili. Che non lo sono necessariamente per motivi innati ma spesso condizionate da motivi storici e materiali. Così come storici, e perciò relativi, sono i criteri per stabilire chi o cosa sarebbe neurotipico.
La questione della “normalità” nel lavoro di Chapman s’inserisce in una prospettiva più ampia, politico-culturale, che superi gli standard del capitalismo, ove non si tratta più di trovare il modo corretto di confezionare menti e comportamenti a suo uso e consumo ma di liberare le potenzialità di ognuno per chiuderla definitivamente con il paradigma “normalità (buona) vs neurodiversità (malata)”.
Forse Chapman e Grandin sono meno distanti di quanto sembri?
Michele Lupo
Robert Chapman
L’impero della normalità
Neurodiversità e capitalismo
Mimesis Edizioni
Collana Postuman3
A cura di Gruppo Ippolita
Traduzione di Gilda Dina
Introduzione di Gruppo Ippolita
Postfazione di Enrico Valtellina
2025, 270 pagine
22 €
Temple Grandin con Betsy Lerner
Pensare senza parole
I doni nascosti di chi ragiona per immagini, pattern e astrazioni
Adelphi
Collana La collana dei casi
Traduzione di Silvio Ferraresi
2025, 400 pagine
28 €