Di fronte al fuoco di Aleksej Nikitin, scrittore ucraino di lingua russa (traduzione di Laura Pagliara per Voland, 2025), è un romanzo complesso e ambizioso perché è la storia di un uomo, di un intero popolo, quello ucraino, e di un mondo, quello sovietico durante la Seconda guerra mondiale.
Su tutti c’è Il’ja Gol’dinov. Poco più che ventenne, ma con una carriera agonistica di tutto rispetto, è ucraino e proviene da una famiglia di ebrei ortodossi, ma si sente russo. Arruolatosi con un Comando del movimento partigiano, che sostiene l’Armata Rossa, finisce in prima linea. E, dopo un violento scontro, con due compagni viene catturato e finisce nello Stalag 346, un campo di concentramento tedesco.
Dove «si barattava di tutto». E dove «una banda di uomini si impossessava dei pacchi dei prigionieri per poi spartirseli tra di loro». Il comando militare tedesco, dopo alcuni giorni, permette a Il’ja − non sapendo che è un ebreo – e a altri prigionieri di tornare a casa, perché i tedeschi non sono «nemici degli onesti contadini e operai ucraini» ma dei «commissari bolscevichi e i giudei che li hanno costretto a prendere le armi».
A questo punto Il’ja entra nella polizia segreta chiamata NKVD (Commissariato del popolo agli Affari interni) sostituita nel 1954 dal KGB. E deve stanare il medico Ivanov.
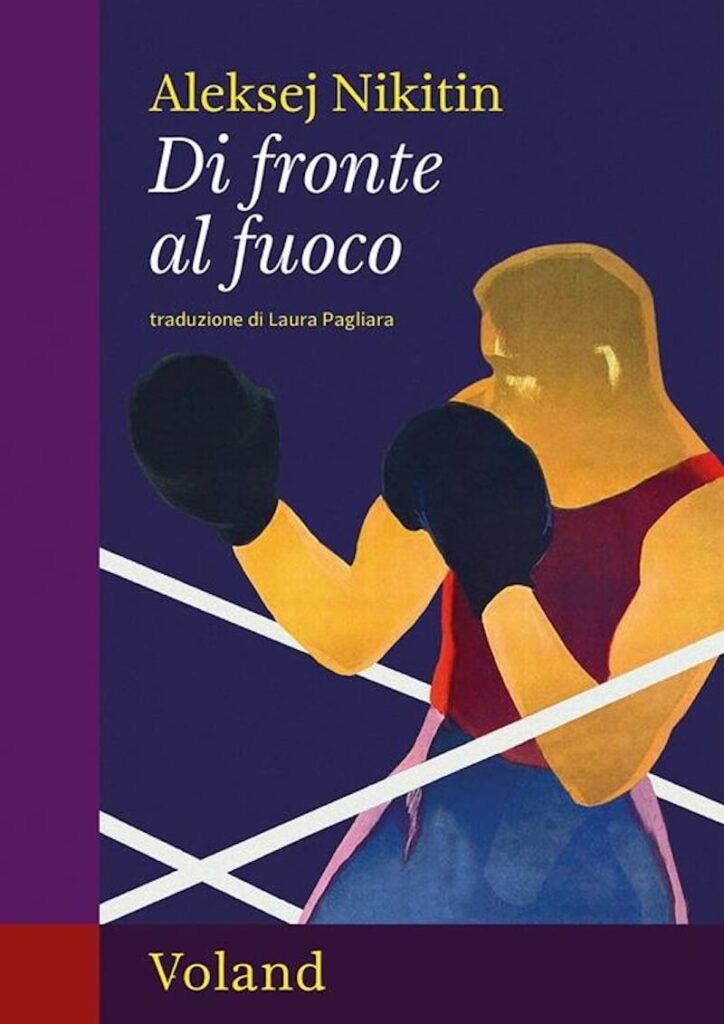
Ma Di fronte al fuoco non è solo la storia di questo ventitreenne, ma anche di Gitl, e di Feliksa.
Gitl, donna di fede ebraica, è rivolta al passato. Ricorda l’Impero, il 1913 – l’anno che reputa più felice – la Rivoluzione d’ottobre e La Grande Carestia che ha piegato l’Ucraina.
Per gli ebrei la vita non è semplice, anche se sotto il regime bolscevico non ci sono più pogrom. È una donna che sente il peso delle sue origini e della sua fede. E ha paura che presto i nazisti rinchiudano lei, la sua famiglia e gli ebrei «nel ghetto come hanno fatto Varsavia, a Cracovia e a Lublino». Gitl è una donna vittima della Storia. Che si sente oppressa e che non riesce a trovare requie.
In lei c’è la consapevolezza che «un terzo di prigionieri traditi da Stalin e dai suoi commissari del popolo sono ucraini. Per i rossi [gli ucraini] sono dei traditori, per i tedeschi non sono nemmeno persone. Stalin non ha tradito solo i prigionieri, ma chiunque è rimasto sotto i tedeschi».
Feliksa, invece, è una donna che aspetta. E non si arrende. Che si trova con una figlia piccola ad affrontare un viaggio nell’entroterra. Dovrebbe arrivare in un villaggio degli Urali dove li attende il fratello più grande di Il’ja, Isja. Ma è costretta separarsi dalla suocera e a fermarsi a Molotov, perché malata.
La sua vita, tra attesa e disperazione per il marito in guerra di cui non si sa nulla, la porta a non fermarsi, a non cedere alla solitudine e alla desolazione. A guerra finita, cerca di sapere di Il’ja ma le autorità non sanno bene che cosa sia lecito dire. Il’ja è morto? O è solo finito, come è accaduto a molti, negli ingranaggi della Storia?
Anche se la guerra è finita c’è un clima di odio e di sospetto. Si impiccano i tedeschi per i massacri di Babij Jar, mentre la gente è «esasperata: non si trova da mangiare, l’industria è in ginocchio, non ci sono alloggi. I nuovi inquilini che sono riusciti a occupare gli appartamenti si scontrano di continuo con quelli di prima della guerra, e ogni fazione ha la sua verità».
La prosa di Nikitin avvolge il lettore. In alcuni momenti si fa epica, in altri estremamente poetica e intima. Fa confluire documenti, momenti fiabeschi e considerazioni storiche. Il dialogo tra personaggi immaginati e veramente esistiti − come se fosse l’occhio di Dio − permette di far sapere al lettore cosa sta succedendo fuori, oltre le vite quotidiane dei personaggi.
Il capitolo intitolato Le preghiere di Reb Nahumè è una vera storia umoristica in perfetto stile yiddish, una piccola fiaba russa, un pezzo di bravura, un momento poetico. In questo capitolo si racconta come Il’ja porti in salvo, dentro lo zaino, un vecchio rabbino.
Attraversano pianure e villaggi con i nazisti alle costole. Mentre il rabbino spiega a Il’ja cosa sia il tempo. Secondo il rabbino gli ebrei conoscono il passato. Guardano al passato, voltano le spalle all’oscurità imminente del futuro. «Non siamo noi che andiamo avanti, è il tempo che va indietro». Il tempo scorre accanto, come il vento, come la luce del sole.
Gli ebrei non guardano a un passato generico, guardano al proprio passato e gli occhi non li distolgono «da migliaia di anni». La forza è nella memoria. Senza gli ebrei avrebbe disperso le «ceneri della memoria sulle valli di Babilonia».
«Siamo sopravvissuti solo perché raccontiamo tutto ciò che ricordiamo», dice il Reb Nahumè. Mentre per i tedeschi e i sovietici «il tempo scorre dal passato al futuro. Desiderano solo lanciarsi in avanti sui loro carrarmati: non possono fare altrimenti», perché il loro tempo «è diretto verso l’ignoto».
Claudio Cherin
Aleksej Nikitin
Di fronte al fuoco
Traduzione di Laura Pagliara
Voland
Collana Sírin
2025, 660 pagine
25 €