Un ministro utilizza un’espressione francamente ripugnante (assai in voga da anni, non solo in Italia, di stampo, a esser generosi, fascistoide), e due giorni dopo dice di non conoscerne il significato. Altri azzardano retoriche puntigliose quanto fallaci sul 25 aprile, altri ancora lavorano scientemente sugli omissis.
Vi è chi sospetta che gli attuali governanti preferiscano passare per ignoranti peggiori di quanto non siano per una precisa strategia: immettere nella già sfibrata democrazia italiana dubbi, parole, concetti e lasciarli circolare fino al punto di assuefazione – ossia, di rottura delle poche già precarissime certezze, come quelle sull’antifascismo e i paradigmi della nostra Costituzione.
Il dissenso al fascismo
Pratica, quella revisionista, antica, ma che forse al momento qualcuno sta cercando di spingere verso un punto di svolta. A noi non resta che tentare di fermarne il processo contrapponendogli parole di segno contrario e che mantengano la barra dritta sulla verità storica. Come fanno da anni a questa parte con le loro ricerche Mario Avagliano e Marco Palmieri – esempi ultimi i volumi, entrambi editi da il Mulino, Il dissenso al fascismo. Gli italiani che si ribellarono a Mussolini (1925-1943), e Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile.
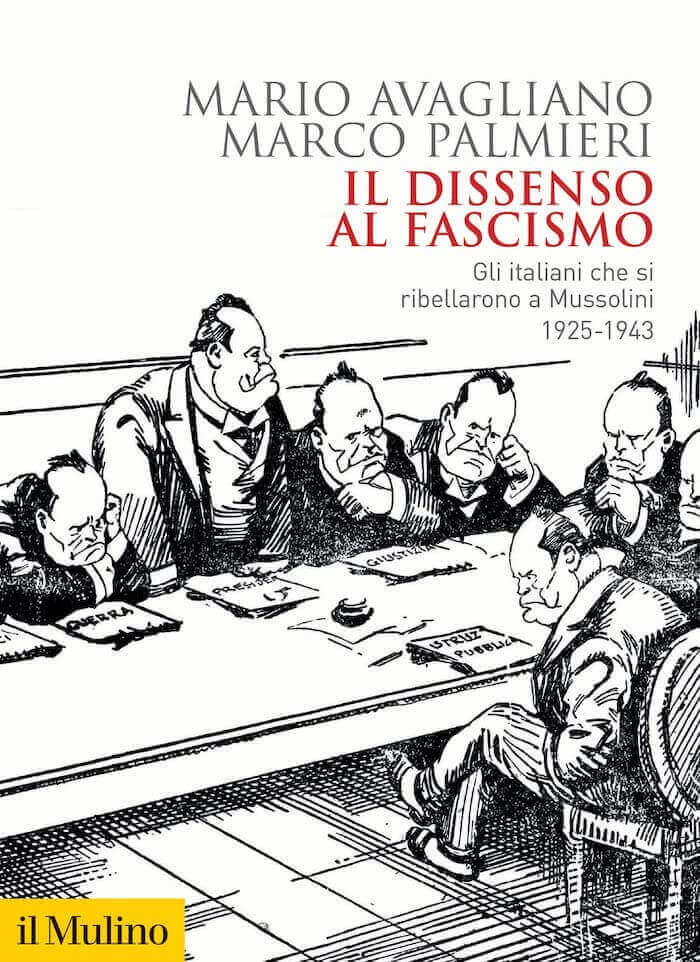
Il primo è un quadro sistematico e riassuntivo sul dissenso nel Ventennio. Difficilissimo, ricordiamolo, quando non impossibile: che lo si detestasse francamente, o non lo si apprezzasse granché, possibilità di contrastare il regime non ce n’erano molte. Come ognuno sa (dovrebbe sapere) da un certo momento in avanti il regime impedì l’esistenza di opposizioni ufficiali.
Il delitto Matteotti e l’osceno discorso che vi dedicò il “batrace stivaluto” (Gadda) prepararono la terra bruciata delle leggi fascistissime. Siamo fra il 1925 e il ‘26. Con la dissoluzione degli altri partiti, del sindacato, della libertà di stampa (di opinione, di parola meglio, visto che in ogni quartiere il regime collocava i suoi ras, e reti di delatori sopprimevano qualsiasi respiro contrario nella culla), la ferocia autoritaria aumentò. Appena in tempo nel ’25 a redigere il Manifesto degli intellettuali antifascisti, che subito dopo dissenso aperto significò carcere, confino, esilio, morte. Col successivo Codice Rocco, l’antifascismo si configurò come vero e proprio reato.
Possibilità di organizzarsi, meno di zero. La gestione poliziesca del territorio obbligava a una cautela estrema, l’apparato repressivo impediva l’accesso agli spazi pubblici di voci dissenzienti. Ovunque, scrivono gli autori, un Capo-zona costituiva il terminale di riferimento: sapeva anche quello che accadeva nei condomini. In quel clima, l’antifascista convinto vive un senso di solitudine pesantissimo, laddove il malumore diffuso può non connotarsi come una chiara, intenzionale presa di posizione politico-ideologica contraria al regime ma tedio mormorante per insoddisfazione sociale, economica…
Poteva manifestarsi in forma di bon mot, barzellette, sarcasmo da bar, parodie e insulti potevano insinuarsi fra una passeggiata e un dopolavoro, in fabbrica o in un ristorante – le orecchie dei fascisti erano sempre all’erta e a caccia di allusioni, doppi sensi e critiche più o meno velate. Talvolta venivano accolte bonariamente ma di solito procuravano guai. A Mussolini alcuni hanno il coraggio di dare del porco, al Tribunale speciale registrano decine di voci a lui riferite (per lo più punendo i responsabili ed evitando di informarne l’interessato): furfante, carogna, camorrista, vigliacco, puttaniere etc. Finiscono male operai, cameriere, fornai, persino alcuni calciatori della nazionale (notoriamente allora fortissima) che rifiutano il saluto romano.
Nell’ambito culturale non andò molto meglio; in breve tempo le non esigue riviste satiriche furono costrette alla chiusura (fra tutte, “L’Asino” e il “Becco giallo”), fatta eccezione per quelle politicamente corrette (nel verso di allora, spicca il “Marc’Aurelio”). Fra le case editrici, sotto osservazione in particolare Einaudi e Laterza (la seconda, piuttosto filosemita).
Dove e quando poterono, agirono clandestinamente gruppi, enclave culturali, fuoriusciti che provarono a farsi sentire nella seconda metà degli anni Trenta, fra il climax del consenso dovuto all’oscena impresa etiopica e la risposta dei volontari alle vicende spagnole. Seguì una stretta più decisa negli accordi col nazismo, una nuova crisi economica e l’emanazione delle leggi razziali (gli ebrei non ricevettero alcuna significativa solidarietà dagli italiani).
Anche con i cattolici non tutto andò secondo i progetti fascisti: il Concordato fu un affare per entrambe le parti, ma la strategia totalitaria che, come ovunque e in qualunque segno, vedeva nell’educazione giovanile il punto di partenza, collideva con le organizzazioni educative della Chiesa, segnatamente con l’Azione Cattolica: nemmeno il Concordato poté evitare il ripetersi di contrasti (nella tradizione storiografica, la forte presenza cattolica è stata perlopiù individuata come una della cause della riduzione del fascismo a un cosiddetto totalitarismo imperfetto). La scuola fu il terreno obbligato della pedagogia fascista: obbligato anche perché lo erano gli insegnanti a seguire più o meno convintamente il suo dettato.
Nulla poté il Manifesto citato sopra, e solo 12 furono i professori universitari che rifiutarono di giurare la fedeltà al regime pretesa da Gentile; giurarono anche molti antifascisti, convinti – o almeno, tali si dichiararono – che affermarono di poter lavorare dal di dentro “per la causa dell’antifascismo”: Calamandrei, Einaudi, Concetto Marchesi fra altri.
Viceversa, molti intellettuali di sinistra, clandestini, va da sé, la presero male, laddove altri lasciarono le lezioni in seguito a ripetuti, violenti attacchi degli studenti fascisti – è il caso dello storico dell’arte Lionello Venturi, o di Giuseppe Antonio Borgese. Nelle scuole superiori il clima era anche peggiore: aveva solo 15 anni il futuro leader Giancarlo Pajetta quando venne espulso da un liceo torinese (e poi incarcerato) per aver trafficato con opuscoli comunisti.
Paisà, sciuscià e segnorine
Con la caduta del regime ovviamente le cose mutarono ma non sempre e ovunque in maniera repentina e convinta: nell’arco del ventennio il consenso al fascismo era stato, ahinoi, assai superiore a quello descritto a volte da una certa storiografia di sinistra. Avagliano e Palmieri lo ricordano anche nell’appassionante volume Paisà, sciuscià e segnorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile.
Meno sistematico, più narrativo, ricco di microstorie che danno quasi manzonianamente il senso delle vite reali, specie in quel meridione, spesso estraneo alla storia ufficiale, che gli autori percorrono dalla Sicilia a Roma non dimenticando che la resistenza è stato un processo soprattutto settentrionale ma ha visto al sud anticiparne avvenimenti e aporie irrisolte anche nel dopoguerra.
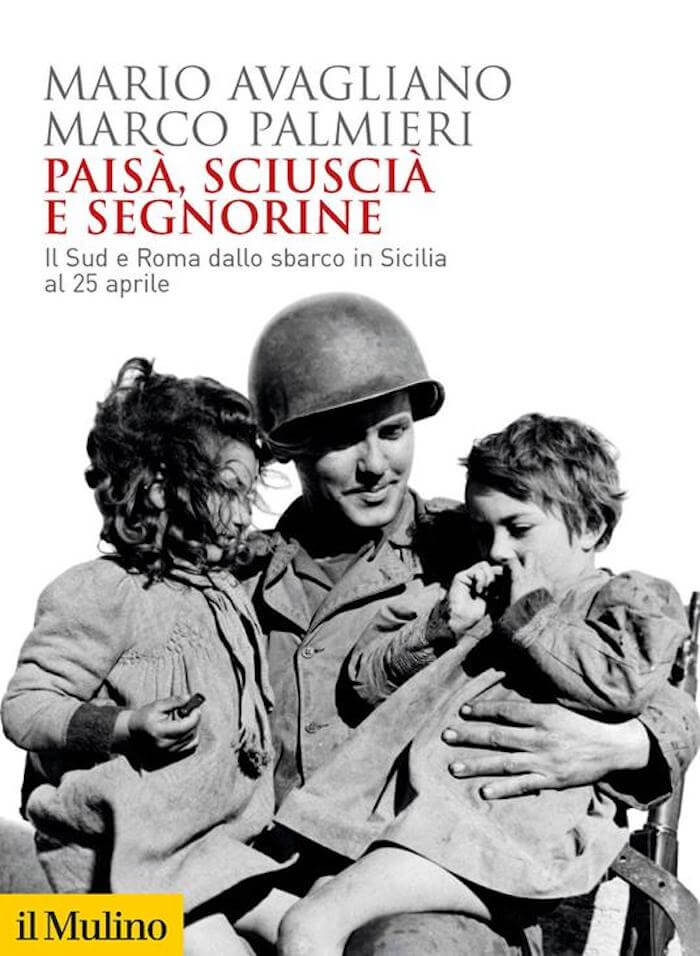
Dallo sbarco degli americani al vuoto di potere che ne conseguì, si attraversa il caos che permise insieme entusiasmi democratici e una fame smisurata. L’inettitudine del re e di Badoglio, fuggiti a Brindisi, il congresso di Bari e la svolta di Salerno con l’ingresso delle forze antifasciste nel governo nazionale, le quattro giornate di Napoli, la liberazione di Roma, – le vicende politico-militari insomma s’intrecciano con quelle della popolazione in carne e ossa alle prese con la tragedia e le sue contraddizioni: il prodigio per occhi e la gioia degli affamati di fronte ai segni della prosperità americana, il cioccolato, le sigarette, le scatolette di cibo e qualche dollaro; e ancora, i paisà (gli italo americani) gli sciuscià (i lustrascarpe) le segnorine (le prostitute, anche occasionali); la delinquenza diffusa.
Due anni di follia; una resistenza forse minore rispetto a quella più nota ma non mancarono le bande partigiane né gli eccidi nazifascisti (numerosi anche in Abruzzo, nel Lazio, in Campania.) C’è un paese razzista (convintamente o meno) che di colpo si trova faccia a faccia con i soldati di colore. Le reazioni si alternano e differiscono fra loro: in molte occasioni ne nascono meticci, ricordati da celebri canzoni, ma l’ostilità si fa sentire, aggravata dalle tragicamente note marocchinate delle truppe africane sotto il comando dei francesi (si veda, ovviamente, La ciociara moraviana, mentre La pelle di Malaparte avrebbe offerto un quadro di quegli anni ancora più nero, scendendo negli inferi di vite ridotte al grado zero dei bisogni primari).
C’erano inoltre i cosiddetti omicidi “armistiziali” – capitava ai soldati americani di sfrecciare sulle jeep a tutta velocità senza curarsi di ammazzare qualcuno; il generale Patton era stato cinicamente assertivo ordinando alle sue divisioni di non farsi troppi problemi con gli italiani. Né collaborò a sufficienza il fantasmatico Regno del Sud che non appoggiò l’idea di organizzare un esercito volontario – d’altronde gli alleati non erano favorevoli al progetto e lo stesso potere del re fu da loro snobbato (al riguardo, Avagliano e Palmieri sembrano assai scettici verso l’idea non poco diffusa che la fuga del governo a Brindisi servisse a conservare un qualche potere istituzionale per il paese).
Altrove, si registra un grande entusiasmo delle popolazioni meridionali verso gli alleati – lo raccontava John Steinbeck nei suoi articoli da inviato di guerra. Ciò fu favorito dalla scelta dei comandi alleati di mandare in avanscoperta i soldati italoamericani – operazione utile a trovare la confidenza e la fiducia necessarie: si veda l’inizio del Paisà rosselliniano, in cui gli abitanti di un piccolo villaggio siciliano indicano ai soldati americani un sentiero per evitare le mine dei tedeschi.
Ma il magma caotico restò tale fino alla liberazione, ferma restando la lezione di Claudio Pavone della guerra civile (ancora ci viene in soccorso il capolavoro di Rossellini. La scena questa volta è ambientata a Firenze ma avrebbe potuto svolgersi a Palermo, Salerno, Latina: “Di là ci sono fascisti che sparano per la rabbia”, dice un partigiano, a sottolineare come i repubblichini continuassero nella loro guerra pur sapendo benissimo di aver perso: odio puro). Odio di una guerra civile che non è meramente e solo ideologica: si pensi al sabotaggio nel 1944 dei decreti Gullo che avrebbero finalmente sottratto parte delle terre ai latifondisti per distribuirle ai contadini.
Infine, caos significa che lo schema resistenziale degli uni contro gli altri contempla variabili meno decifrabili: in quegli anni, e ancora dopo, aleggia quella sorta di zona grigia altrove e per questioni più specifiche descritta superbamente da Primo Levi.
Scrive in un recente libro (Processo alla Resistenza, Einaudi), di cui magari parleremo in altra occasione, la giovane storica Michela Ponzani:
I partigiani, visti come ribelli fuorilegge, non erano stati sempre compresi dalla popolazione civile, e l’atteggiamento antisolidaristico dimostrato verso di loro ne era stata una riprova. Contadini e montanari che si erano opposti alle razzie di bestiame e alle requisizioni di alimenti, quando le fasi più calde del conflitto li avevano resi necessari per la sopravvivenza delle brigate sul territorio; abitanti delle città che avevano assistito impassibili alle azioni gappiste, ispirate alla “caccia libera” contro fascisti e tedeschi, non senza conseguenze in termini di ritorsioni contro i civili. Quello della Resistenza con le popolazioni colpite dalle catastrofiche condizioni di guerra (sinistrati, sfollati, costantemente alla disperata ricerca di cibo) era stato un rapporto difficile, intricato, articolato nel tempo e mutevole a seconda dei contesti in cui la lotta partigiana era stata combattuta”.
Dopo, nell’Italia liberata, contrariamente a quanto si crede, furono in molti a non riconoscere ai partigiani lo stigma dei vincitori, anzi, massimamente agli occhi dei magistrati (rimasti interiormente fascisti) molte volte furono considerati alla stregua di banditi. E ancora oggi questa ricostruzione trova i suoi fiancheggiatori.
Michele Lupo
- Mario Avagliano e Marco Palmieri
Il dissenso al fascismo
Gli italiani che si ribellarono a Mussolini (1925-1943)
il Mulino
Collana Biblioteca storica
2022, 560 pagine
30 € - Mario Avagliano e Marco Palmieri
Paisà, sciuscià e segnorine
Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile
il Mulino
Collana Biblioteca storica
2021, 504 pagine
26 €